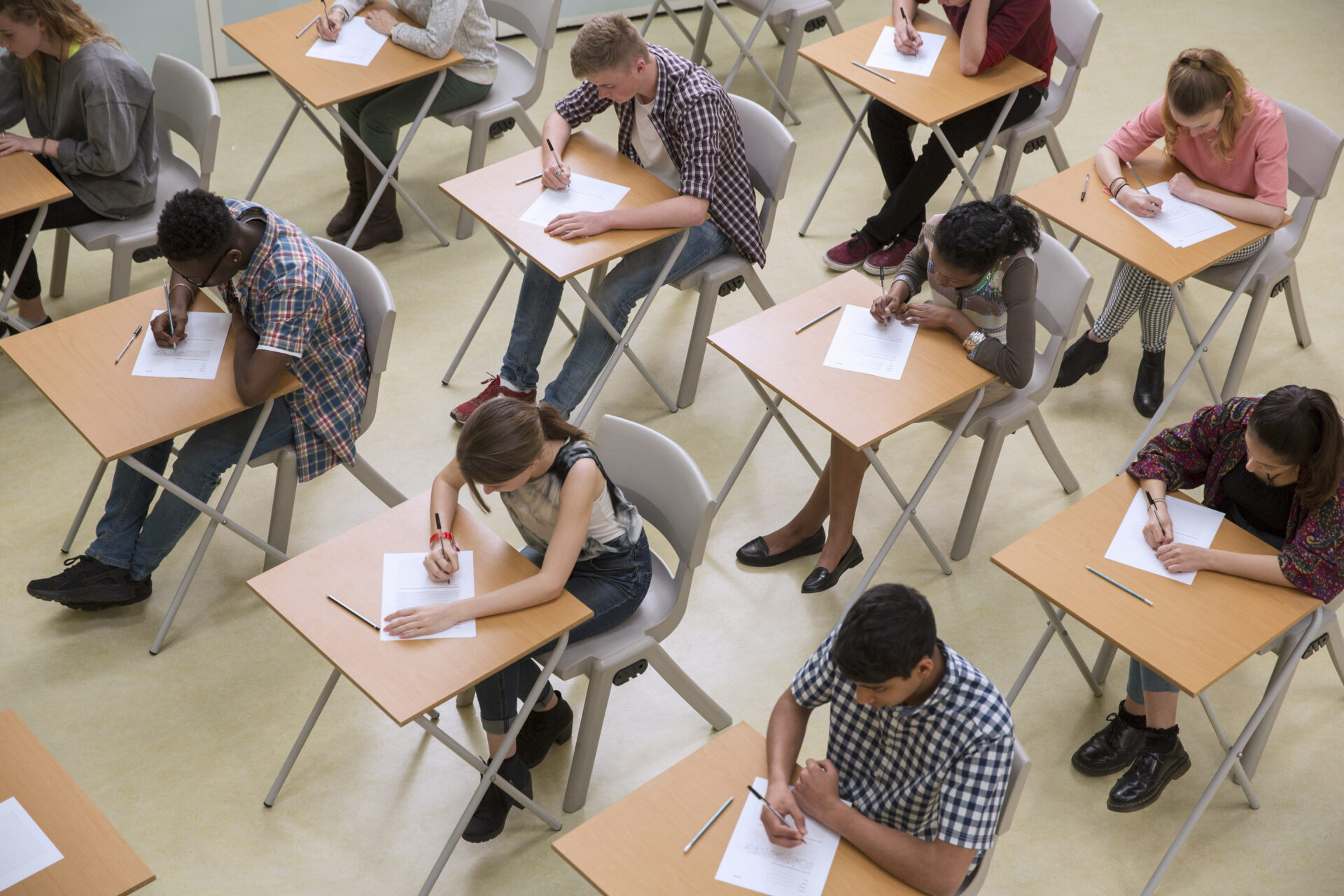Valutazione Scuola Primaria 2020
La norma è superata da norma successiva
LINEE GUIDA
La formulazione dei giudizi descrittivi
nella valutazione periodica e finale della scuola primaria
Introduzione
La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla
progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle
potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e
potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.
La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto
numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in
trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si
manifestano i risultati degli apprendimenti. D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una
descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle
dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Appare dunque necessario evidenziare come la
valutazione sia lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze
realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi
livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo
miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico1 .
L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le
informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato
osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.
D’altro canto, chiare indicazioni che vanno in questa direzione sono già presenti nel decreto
legislativo n. 62/20172 , che offre un quadro normativo coerente con le modifiche apportate decreto legge n. 22/2020 (art. 1 comma 2-bis). All’articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 è sottolineato come
la valutazione abbia a “oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento”, assegnando ad essa
una valenza formativa ed educativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti. La valutazione,
inoltre “documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. Pertanto anche le modalità individuate
per l’espressione e la comunicazione dei diversi livelli di apprendimento devono essere adeguate alle
finalità sopra espresse, oltre che rispondenti a quanto previsto nei successivi articoli del decreto
legislativo n. 62/2017, letto in combinato disposto con il DPR n. 275/19993 , in particolare con
l’articolo 4. Sempre il decreto legislativo n. 62/2017 prevede che la valutazione sia coerente con l’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012 (di seguito
Indicazioni Nazionali), richiedendo che essa sia espressa “in conformità con i criteri e le modalità
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. A questo proposito,
può essere utile aggiungere che il DPR n. 275/1999 all’articolo 4, comma 4 stabilisce che le scuole
“Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa
nazionale”, definendo quindi anche il modello del documento di valutazione (a differenza di quello
della Certificazione delle competenze che è nazionale, come previsto dall’articolo 10, comma 3 del DPR
n. 275/1999).
Da ultimo, la prospettiva della valutazione per l’apprendimento è presente nel testo delle Indicazioni
Nazionali, ove si afferma che la valutazione come processo regolativo, non giunge alla fine di un
percorso, “precede, accompagna, segue” ogni processo curricolare e deve consentire di valorizzare i
progressi negli apprendimenti degli allievi.
In base a questo quadro teorico-normativo le presenti Linee Guida offrono ai docenti orientamenti
per la formulazione del giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale e definiscono quadri di
riferimento e modelli che costituiscono, ai fini della necessaria omogeneità e trasparenza, uno standard
di riferimento che le istituzioni scolastiche possono implementare.
Dagli obiettivi di apprendimento ai giudizi descrittivi
Come stabiliscono le Indicazioni Nazionali, “le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo…
[Essi] rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da
percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo”. In questo
senso, le Indicazioni Nazionali – come declinate nel Curricolo di Istituto e nella programmazione
annuale della singola classe – costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e
definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di
ciascun alunno in ogni disciplina. Più specificamente, la normativa indica che “gli obiettivi di
apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze”.
Allo scopo di procedere all’elaborazione del giudizio descrittivo e per facilitare i docenti
nell’individuare quali obiettivi di apprendimento sono esplicito oggetto di valutazione per ogni classe e
ogni disciplina, sono forniti di seguito alcuni chiarimenti.
- Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico
ed esplicito da poter essere osservabili. Ai fini della progettazione annuale, i docenti possono
utilizzare gli obiettivi così come proposti dalle Indicazioni Nazionali oppure riformularli, purché
espressi in modo che siano osservabili, che non creino ambiguità interpretative e in coerenza
con i traguardi di sviluppo delle competenze. - Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere in atto, sia il
contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce. Più specificamente:
▪ l’azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. Nel descrivere i processi
cognitivi è dunque preferibile evitare l’uso di descrittori generici e utilizzare verbi, quali
ad esempio elencare, collegare, nominare, riconoscere, riprodurre, selezionare,
argomentare, distinguere, stimare, generalizzare, fornire esempi, ecc, che identificano
tali manifestazioni con la minore approssimazione possibile. In tal modo gli obiettivi
sono espressi così da non ingenerare equivoci nei giudizi valutativi;
▪ i contenuti disciplinari possono essere di tipo fattuale (terminologia; informazioni; dati;
fatti; …), concettuale (classificazioni; principi; …), procedurale (algoritmi; sequenze di
azioni; …) o metacognitivo (imparare a imparare; riflessione sul processo; …). Nel
repertorio di obiettivi scelti come oggetto di valutazione è importante che siano
rappresentate in modo bilanciato le diverse tipologie.
I nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali costituiscono il riferimento per identificare eventuali
aggregazioni di contenuti o di processi di apprendimento.
Livelli e dimensioni dell’apprendimento
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento
individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione
periodica e finale.
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola
primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:
● avanzato;
● intermedio;
● base;
● in via di prima acquisizione.
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono
di formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare, nella letteratura pedagogico-didattica e nel
confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola, quattro dimensioni che sono alla base della
definizione dei livelli di apprendimento.
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno
specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è
riscontrabile alcun intervento diretto del docente;
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto
l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata
dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi
o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come
nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al
tipo di procedura da seguire;
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;
d) la continuità nella manifestazione dell’apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento
è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi
è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.
I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, tenendo
conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, nella Tabella 1, anche in questo caso in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze.
Tabella 1 – I livelli di apprendimento.
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in
modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la
normativa prevede che “[l]’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa,
attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (…).” (art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017). È dunque importante che i docenti strutturino percorsi educativo-
didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie nell’individuazione di eventuali problematiche legate all’apprendimento, mettendo in atto strategie di individualizzazione e
personalizzazione4 .
Si ricorda che già le Indicazioni Nazionali richiamano i docenti a promuovere un processo continuo
di circolarità e ricorsività fra attività di progettazione e processi di valutazione, che “attiva le azioni da
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine secondo
una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo”.
Nell’esercizio della propria autonomia, ogni istituzione scolastica può individuare ulteriori
dimensioni (ad esempio: saper spiegare i procedimenti seguiti per svolgere il compito richiesto; mettere
a confronto differenti opinioni, soluzioni, strumenti, …; saper tornare sui propri errori e
autocorreggersi; fare collegamenti fra le discipline; ecc.), con le quali integrare questa progressione,
tenendo conto che è comunque richiesta un’esplicitazione chiara dei criteri con cui si descrivono i
diversi livelli, in base a tutte le dimensioni definite, per far sì che i contenuti dei documenti valutativi
non si prestino a interpretazioni contrastanti. La definizione dei livelli è quindi riportata nel PTOF e nel
Documento di valutazione di ogni istituzione scolastica.
Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è
espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti
contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La
valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano
didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre
2010, n. 170.
Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di
apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il
piano didattico personalizzato.
Il documento di valutazione
Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la
descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell’apprendimento rilevati in modo
continuativo.
Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall’alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio
descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi
apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore
potenziamento o sviluppo e garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi
successivi.
Esistono diverse modalità con cui esprimere la valutazione descrittiva nel Documento di
Valutazione: in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni istituzione
scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, elabora il Documento di Valutazione, tenendo conto
sia delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell’efficacia e della trasparenza
comunicativa nei confronti di alunni e genitori. Anche nella forma grafica, si possono utilizzare modelli
e soluzioni differenti, che devono comunque contenere:
- la disciplina;
- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);
- il livello;
- il giudizio descrittivo.
Qualora il giudizio descrittivo non contenga già l’esplicitazione dei criteri determinati dall’istituzione
scolastica per differenziare i diversi livelli, sarà presente nel documento di valutazione una legenda che
descrive i livelli in base alle dimensioni di apprendimento
Si riporta di seguito, a puro titolo esemplificativo, una possibile impostazione e soluzione grafica che
può essere adottata per il documento di valutazione. Tale esempio è da considerare “base” e può essere
implementato o integrato secondo modalità individuate dalle singole istituzioni scolastiche,
nell’esercizio della loro autonomia.
La tabella A1 riporta gli obiettivi oggetto di valutazione nella progettazione annuale, distribuiti nei
diversi livelli a seconda degli apprendimenti conseguiti dagli alunni.